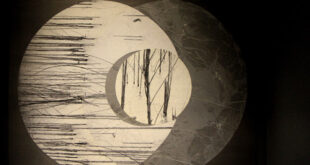Cinque anni fa è stato lanciato il primo sciopero femminista transnazionale. È stato l’innesco di un processo di politicizzazione che ha modificato irreversibilmente le aspettative di milioni di donne e persone Lgbtq+, che hanno fatto della lotta contro la violenza maschile un comune progetto di sovversione sociale. Oggi, verso la mobilitazione transnazionale del 27 novembre contro la violenza maschile sulle donne, scommettiamo sul fatto che quelle aspettative siano ancora vive e ribollenti sotto la polvere desolante della realtà presente.
La pandemia ha schiacciato coloro che hanno infiammato le lotte femministe sotto il peso di una coazione sociale durissima che investe il lavoro produttivo e riproduttivo, salariato o meno. Lungo le catene transnazionali del lavoro e della cura, nei servizi essenziali, nelle case, nelle fabbriche e nelle scuole, le donne stanno faticando e combattendo per non essere licenziate, per non cadere in povertà, per non perdere il permesso di soggiorno, per non essere obbligate ad abbassare la testa di fronte alle molestie sessuali quotidiane. La violenza maschile è aumentata ovunque. In Italia quasi cento donne sono state uccise dall’inizio dell’anno per mano di un uomo. Si sono moltiplicati gli episodi di violenza contro le persone Lgbtq+ e l’affossamento del disegno di legge Zan ha dato a quella violenza una legittimazione istituzionale. L’urgenza della mobilitazione lanciata in Italia da Non Una di Meno è lampante. La piazza del 27 novembre – chiamata da una grande assemblea nazionale a Bologna in connessione con la Trans Freedom March del 20 ‒ deve offrire la forza di un grande corpo collettivo a ogni singola donna che non accetta di vivere sotto la minaccia costante della violenza maschile, a ogni lavoratrice che voglia urlare il suo rifiuto dello sfruttamento domestico e salariato, a ogni migrante che non sopporta di essere sequestrata dal marito o padrone da cui dipendono i suoi documenti, a chiunque pretende di praticare la propria libertà sessuale senza essere criminalizzata e punita. Anche se da tempo il movimento non si manifesta nelle grandissime mobilitazioni transnazionali che hanno caricato la marea della sua forza di massa, noi sappiamo che la marea non è solo una continua e violenta mareggiata ma esiste anche quando si ritrae. La marea vive in ogni lotta singolare e nelle piazze che nonostante tutto continuano a riempirsi, come quelle che in Polonia reclamano la libertà di abortire per non morire di una maternità imposta per legge. E allora dobbiamo tenere vivo l’orizzonte dello sciopero femminista e transfemminista alimentando l’aspettativa e la pretesa che esso ha generato di interrompere la riproduzione patriarcale e razzista della società neoliberale.
Questa via oggi è resa più impervia dagli effetti sociali della pandemia, che ha complicato le condizioni di vita e lavoro e quindi anche la possibilità di organizzarsi. Il problema, però, riguarda anche i discorsi e le ipotesi politiche con cui ci misuriamo in questa situazione. Dobbiamo sopportare da troppo tempo la visibilità del femminismo transescludente venuto alla ribalta in Italia attorno al dibattito sul disegno di legge Zan e per le sue improponibili alleanze internazionali con le politiche anti-gender delle destre reazionarie. Oggi è fondamentale un discorso femminista capace di costruire connessioni politiche contro l’ordine sociale patriarcale, e per questo non c’è niente di femminista nella pratica di un discorso che per proteggere la differenza sessuale da un assedio immaginario finisce per giustificare la violenza contro le persone Lgbtq+. Non è femminismo se ignora una moltitudine di soggetti che vogliono praticare la libertà sessuale senza essere percossi, insultati o derisi. Non è femminismo se nega che quella libertà oggi non è un fatto privato, ma una rivendicazione pubblica e collettiva contro il comando patriarcale che vorrebbe assegnare a ciascun sesso comportamenti e ruoli di genere legittimi. Non è femminismo se cancella la forza antiautoritaria della libertà sessuale. La posizione transescludente di questa minoranza settaria danneggia le donne, perché le identifica con le funzioni procreative che il patriarcato impone loro come un destino. Per contrastare questa posizione dovremmo però guardarci dal dire che l’eterosessualità è per tutte le donne un privilegio o che riconoscersi come donne sia il segno dell’accettazione dei comportamenti e dei ruoli di genere imposti dal dominio maschile. Il fatto di essere eterosessuale o cisgender non fa di una donna migrante che affronta i confini per sfuggire alla povertà e alla violenza maschile, o di una precaria che sbarca il lunario a pochi euro all’ora, una privilegiata. Un’operaia che sciopera per turni di lavoro che le permettano di occuparsi di sua figlia non è obbediente all’ordine patriarcale solo perché ha scelto di essere madre. Togliere il femminismo dalle mani delle TERF significa rifiutare le contrapposizioni identitarie e di stilare gerarchie del privilegio e dell’oppressione. Significa far valere una differenza politica che non esprime un’identità e quindi non esclude, ma produce connessioni reclamando uno schieramento contro l’ordine patriarcale della società. Per tenere vivo il processo di comunicazione politica innescato dallo sciopero femminista e transfemminista è necessario riaffermare che la lotta contro la violenza maschile deve aggredire contemporaneamente le condizioni sociali in cui essa viene esercitata e contestata.

Rifiutare le contrapposizioni identitarie è essenziale nel momento in cui queste stanno diventando uno strumento del governo patriarcale della ricostruzione post-pandemica. Dal Texas all’Ungheria, dalla Turchia all’Italia, le politiche anti-gender si uniscono a quelle antiabortiste con l’intento di ristabilire l’“ordine naturale” dei rapporti sociali mettendoli al riparo da ogni contestazione. Sarebbe tuttavia un errore pensare di poter organizzare l’iniziativa politica immaginando di avere davanti un omogeneo attacco repressivo o ultraconservatore. L’attacco reazionario alla libertà di aborto in Texas avviene nel contesto di un mandato presidenziale ‘progressista’ e in presenza di un governo federale composto da persone di diversi orientamenti sessuali, generi ed etnie alle quali è richiesto di continuare ad applicare, con la legittimazione conferita dall’identità, politiche neoliberali di distribuzione della spesa pubblica e di controllo dei confini. L’Ungheria è parte di un’Unione Europea che fa della parità di genere la propria bandiera, si dichiara amica delle persone Lgbtq+, rimprovera aspramente i suoi Stati orientali per le loro politiche repressive, salvo poi sospendere il giudizio quando quegli stessi Stati servono a contenere i movimenti delle e dei migranti. La criminalizzazione delle persone Lgbtq+ nell’Europa dell’Est, giustificata come tutela delle donne in quanto mogli e madri, è necessaria per consolidare la famiglia come unico canale legittimo di accesso a servizi e benefici minimi. All’opposto, le politiche neoliberali delle quote non riguardano soltanto una rappresentanza politica organizzata per categorie – e come tale refrattaria a ogni ipotesi di intersezione politica – ma anche la distribuzione di porzioni misere di welfare destinate a gruppi sociali specifici codificati come ‘minoranze’. In tutti i casi viene rafforzata la divisione sessuale del lavoro contestata da donne, operaie, precarie e migranti che quotidianamente mettono in questione l’organizzazione razzista e sessista dello sfruttamento. Sul fronte reazionario e su quello ‘progressista’ siamo davanti a una formalizzazione giuridica oppure a una criminalizzazione delle posizioni e dei comportamenti come ‘identità’ che permette di reprimere o governare la libertà sessuale e amministrare l’accesso alle prestazioni sociali attraverso la frammentazione. Muoversi politicamente in questo orizzonte significa allora contrastare la frammentazione prodotta dalle politiche delle identità riaffermando la capacità di connettere posizioni diverse a partire dal rifiuto della violenza maschile, come è accaduto nel corso della mobilitazione transnazionale lanciata il primo luglio dalla rete EAST.
Su questo terreno si gioca una partita delicata, perché è evidente che le battaglie per i diritti, per conquistare quote di ricchezza sociale, per ottenere tutele contro la precarietà intensificata dalla pandemia o risorse per sostenere i percorsi di fuoriuscita dalla violenza sono inaggirabili. È necessario amplificare queste battaglie senza soffocare l’immaginazione politica riducendo l’orizzonte del movimento al piano della mediazione istituzionale. Il riconoscimento dei diritti non esaurisce le pretese soggettive che lo sciopero femminista e transfemminista ha messo in movimento. La stessa lotta per sostenere il ddl Zan in Italia è andata oltre il disegno di legge, perché accanto alla rivendicazione di misure immediate per arginare la violenza contro le persone Lgbtq+ ha espresso l’urgenza di affermare inequivocabilmente l’illegittimità di quella violenza come pratica punitiva verso chi non si conforma all’ordine sociale dei generi che il patriarcato cerca di imporre sulla base del sesso. Questa aspirazione antagonista va in tutti i modi sostenuta per tenere aperto un processo politico capace di intercettare la rabbia di milioni di donne che con lo sblocco dei licenziamenti rischiano di essere respinte nel privato perché in quanto donne, madri, o mogli ‘naturalmente’ incaricate della cura non sono abbastanza disponibili per essere sfruttate a tempo pieno; creare le condizioni di visibilità politica per centinaia di migliaia di migranti impiegate nella cura, nella sanificazione o nell’agricoltura, che tutti i giorni combattono contro l’isolamento e il silenzio imposti dalla coazione del permesso di soggiorno; amplificare la forza antiautoritaria di cui sono cariche le battaglie per la libertà sessuale, con la loro contestazione della famiglia, della divisione sessuale del lavoro e della gerarchia patriarcale dei generi, come terreno su cui si schierano insieme donne e persone Lgbtq+. Tutto questo è quanto mai necessario per sfidare l’autoritarismo che sostiene la pianificazione razzista e patriarcale della ricostruzione post-pandemica, per produrre schieramenti capaci di dare forza a ogni lotta particolare senza che questa si esaurisca nella sua particolare identità.
 Per fare questo dobbiamo continuare ostinatamente a praticare la prospettiva transnazionale che in questi anni ha alimentato la marea. Non esiste una pratica di lotta più avanzata da applicare come modello universalmente valido, con un avanguardismo che immagina di correre in avanti mentre lascia milioni di donne nell’anticamera della storia. In questo momento in Afghanistan praticare e mostrare pubblicamente qualsiasi forma di libertà sessuale che contesti l’imperativo di riprodurre una specie obbediente è un rischio mortale. Mentre si gestiscono le risorse del Recovery Plan per fare strada a un nuovo regime di accumulazione ecologica del capitale, si riconfigurano gerarchie nazionali e sessuate dei salari e del welfare che alimenteranno le invisibili catene transnazionali del valore e della cura. Centinaia di migliaia di migranti stanno spingendo lungo i confini orientali e meridionali dell’Europa, dove stupri e violenza continuano a essere pratiche ordinarie di contrasto della loro libertà di movimento. Il messaggio di questa violenza maschile e razzista non è confinabile, perché consiste in un’ingiunzione globale patriarcale alla sottomissione. Questo imperativo alla sottomissione è la condizione materialmente e simbolicamente essenziale per la riproduzione di un’autorità che pretende di essere indiscutibile per tutte e per ciascuno. Per sfidare questa autorità bisogna combatterla alla sua stessa altezza, rimettendo al centro la lotta contro la violenza maschile come necessità inaggirabile della nostra libertà. Non possiamo dire, oggi, se l’8 marzo la marea femminista e transfemminista si ripresenterà con la mareggiata di un grande sciopero transnazionale. Ma l’8 marzo non sarà un rito se, a partire dal 27 novembre e oltre, con la forza propulsiva dell’assemblea di Non Una di Meno, riusciremo a tenere aperto il processo dello sciopero riunendo le moltissime voci contro la violenza patriarcale in un unico grido collettivo di rivolta.
Per fare questo dobbiamo continuare ostinatamente a praticare la prospettiva transnazionale che in questi anni ha alimentato la marea. Non esiste una pratica di lotta più avanzata da applicare come modello universalmente valido, con un avanguardismo che immagina di correre in avanti mentre lascia milioni di donne nell’anticamera della storia. In questo momento in Afghanistan praticare e mostrare pubblicamente qualsiasi forma di libertà sessuale che contesti l’imperativo di riprodurre una specie obbediente è un rischio mortale. Mentre si gestiscono le risorse del Recovery Plan per fare strada a un nuovo regime di accumulazione ecologica del capitale, si riconfigurano gerarchie nazionali e sessuate dei salari e del welfare che alimenteranno le invisibili catene transnazionali del valore e della cura. Centinaia di migliaia di migranti stanno spingendo lungo i confini orientali e meridionali dell’Europa, dove stupri e violenza continuano a essere pratiche ordinarie di contrasto della loro libertà di movimento. Il messaggio di questa violenza maschile e razzista non è confinabile, perché consiste in un’ingiunzione globale patriarcale alla sottomissione. Questo imperativo alla sottomissione è la condizione materialmente e simbolicamente essenziale per la riproduzione di un’autorità che pretende di essere indiscutibile per tutte e per ciascuno. Per sfidare questa autorità bisogna combatterla alla sua stessa altezza, rimettendo al centro la lotta contro la violenza maschile come necessità inaggirabile della nostra libertà. Non possiamo dire, oggi, se l’8 marzo la marea femminista e transfemminista si ripresenterà con la mareggiata di un grande sciopero transnazionale. Ma l’8 marzo non sarà un rito se, a partire dal 27 novembre e oltre, con la forza propulsiva dell’assemblea di Non Una di Meno, riusciremo a tenere aperto il processo dello sciopero riunendo le moltissime voci contro la violenza patriarcale in un unico grido collettivo di rivolta.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione