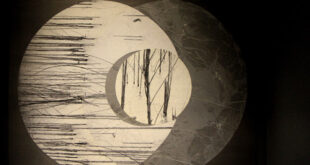Ciò che le donne stanno vivendo non è una novità, ma la situazione è senza precedenti. Non è una novità che siano considerate essenzialmente destinate alla maternità e alla cura, animate da un irresistibile spirito di abnegazione e inclini al sacrificio di sé. Non è una novità che queste qualità «essenzialmente femminili» siano celebrate socialmente e svalutate economicamente tanto che, quando sono messe al lavoro, sono pagate poco o non pagate affatto. Si sa: alle donne piace donarsi senza chiedere niente in cambio. Ma è senza precedenti che l’aggettivo «essenziale» sia messo accanto a tutti quei lavori ‒ svolti peraltro prevalentemente dalle donne ‒ che non si possono fermare perché altrimenti verrebbero meno la produzione di merci e la riproduzione della società. Non per questo le donne vengono risarcite con qualche forma di «ristoro». Al contrario: dentro e fuori casa sono sommerse di lavoro perché la società degli uomini e del capitale sia salvata dal contagio. Nel presente pandemico la loro identificazione patriarcale e razzista con posizioni e funzioni tanto indispensabili quanto subalterne viene affermata con una violenza sempre più intensa. Questa violenza sociale è l’altra faccia di quella domestica, degli stupri, delle molestie sessuali che durante la pandemia sono aumentate in maniera impressionante. Contro tutte queste violenze, negli ultimi anni Non una di Meno e migliaia di donne e persone Lgbtq hanno preteso di interrompere la riproduzione sociale della loro subalternità opponendo alla violenza maschile la forza collettiva e transnazionale dello sciopero femminista e transfemminista. Oggi quella forza deve essere riattivata per mostrare che lo sciopero è indispensabile per far fronte al governo della pandemia e ai piani di ricostruzione che rischiano di rinsaldare le gerarchie sessuate che danno forma alla società. Noi pensiamo che nella giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne del 25 novembre sia quanto mai necessario mostrare la continuità e la relazione reciproca tra le violenze domestiche, quella razzista e quelle che le donne devono affrontare come lavoratrici economicamente essenziali e sistematicamente sfruttate. La sfida è di costruire una forza politica essenziale contro violenze, oppressione e sfruttamento.
Ciò che le donne stanno vivendo non è una novità, ma la situazione è senza precedenti. Non è una novità che siano considerate essenzialmente destinate alla maternità e alla cura, animate da un irresistibile spirito di abnegazione e inclini al sacrificio di sé. Non è una novità che queste qualità «essenzialmente femminili» siano celebrate socialmente e svalutate economicamente tanto che, quando sono messe al lavoro, sono pagate poco o non pagate affatto. Si sa: alle donne piace donarsi senza chiedere niente in cambio. Ma è senza precedenti che l’aggettivo «essenziale» sia messo accanto a tutti quei lavori ‒ svolti peraltro prevalentemente dalle donne ‒ che non si possono fermare perché altrimenti verrebbero meno la produzione di merci e la riproduzione della società. Non per questo le donne vengono risarcite con qualche forma di «ristoro». Al contrario: dentro e fuori casa sono sommerse di lavoro perché la società degli uomini e del capitale sia salvata dal contagio. Nel presente pandemico la loro identificazione patriarcale e razzista con posizioni e funzioni tanto indispensabili quanto subalterne viene affermata con una violenza sempre più intensa. Questa violenza sociale è l’altra faccia di quella domestica, degli stupri, delle molestie sessuali che durante la pandemia sono aumentate in maniera impressionante. Contro tutte queste violenze, negli ultimi anni Non una di Meno e migliaia di donne e persone Lgbtq hanno preteso di interrompere la riproduzione sociale della loro subalternità opponendo alla violenza maschile la forza collettiva e transnazionale dello sciopero femminista e transfemminista. Oggi quella forza deve essere riattivata per mostrare che lo sciopero è indispensabile per far fronte al governo della pandemia e ai piani di ricostruzione che rischiano di rinsaldare le gerarchie sessuate che danno forma alla società. Noi pensiamo che nella giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne del 25 novembre sia quanto mai necessario mostrare la continuità e la relazione reciproca tra le violenze domestiche, quella razzista e quelle che le donne devono affrontare come lavoratrici economicamente essenziali e sistematicamente sfruttate. La sfida è di costruire una forza politica essenziale contro violenze, oppressione e sfruttamento.
La libertà di abortire e la maternità salariata
Lo sciopero delle donne in Polonia è stato molto più di una risposta all’inaccettabile sentenza della Corte costituzionale che ha tentato, senza riuscirci, di proibire anche l’aborto terapeutico, molto più della difesa dell’ultimo baluardo giuridico, peraltro quasi solo simbolico, della libertà di non essere madri. È stato la contestazione complessiva di una società che ha bisogno di identificare le donne con la maternità per fissarle in una posizione considerata naturale, facendole diventare delle procreatrici per lo Stato, supplementi di un welfare inesistente, madri e lavoratrici sempre disponibili. Tra le richieste delle donne in sciopero c’è anche l’estensione del «Piano famiglia 500+», che prevede un sussidio di 120 € al mese per ogni figlio successivo al primo. Rifiutando la maternità coatta, le donne polacche trasformano anche quella salariata dallo Stato in uno scontro sulla loro complessiva libertà. Connettere la rivendicazione della libertà di abortire con la lotta per l’estensione delle prestazioni sociali diviene così una lotta sulle modalità materiali con cui lo Stato polacco pretende di incardinare le donne nelle gerarchie cattoliche e patriarcali della famiglia. Lo sciopero delle donne polacche è essenziale perché ha permesso loro di far valere collettivamente il loro potere sociale contro la riproduzione dell’oppressione maschile.
Ciò che accade in Polonia mostra che la nostra iniziativa femminista deve fare i conti tanto con il bisogno diffuso e reale delle donne di essere sollevate dagli effetti sociali della pandemia, quanto con i criteri patriarcali e razzisti che implicitamente o esplicitamente regolano la gestione dei sussidi. Da questo punto di vista, la Polonia è forse un caso limite, ma non isolato. L’Unione Europea pone come condizione per accedere al Recovery Fund il rispetto dello Stato di diritto, criterio fondamentale per regolare i rapporti tra gli Stati all’interno dell’UE e tra i suoi cittadini, preferibilmente maschi e bianchi. Uno Stato di diritto si preoccupa giustamente della libertà di stampa e dell’autonomia delle corti supreme di giustizia, ma mostra il suo rovescio quando si tratta della libertà di aborto in Polonia, della legge sul lavoro straordinario obbligatorio in Ungheria (slave law), della libertà delle migranti sistematicamente negata o della violenza sulle donne esercitata da padri, fidanzati e mariti all’interno dei sacri e inviolabili confini domestici. La «parità di genere» che l’UE indica tra gli obiettivi da perseguire nella spesa dei fondi di recupero è il segno che le pretese avanzate in questi anni dalle donne con la loro mobilitazione globale sono impossibili da ignorare. Non è però ancora stabilito come questa indicazione verrà applicata nei diversi paesi e dai diritti dei loro Stati. Anche all’interno dell’UE si dovrà stabilire se le prestazioni sociali saranno vincolate alle condizioni che producono la subalternità delle donne o se le donne stesse, e non i mariti o le famiglie, potranno esserne titolari per decidere sulla propria vita.
Il Family Act in discussione in Italia insieme alla legge di bilancio si porta il suo marchio e la sua minaccia già nel nome. Non a caso definisce le donne il «secondo percettore di reddito» e prevede di colmare questa condizione di svantaggio con un «assegno unico per il figlio», una semplificazione delle misure a sostegno della «genitorialità» che avrà, tra gli altri vantaggi, quello di offrire a Confindustria un ennesimo dono portando alla progressiva abolizione dell’assegno familiare a carico dei datori di lavoro. In omaggio alla parità di genere, l’assegno dovrà essere equamente diviso tra i due genitori, come se tra un padre e una madre vi fosse simmetria in termini di impegno e tempo dedicato alla prole, e come se la divisione sessuale del lavoro domestico e di cura non fosse tra le prime cause che producono «percettori di reddito» di prima e di seconda categoria. Le donne potranno accedere a questa risorsa soltanto come madri incaricate di colmare il deficit demografico del paese. Le migranti invece potranno ottenerla solo se rispettano quei requisiti minimi di soggiorno ormai impossibili da ottenere. È quindi più probabile che questo sussidio arriverà nelle loro tasche sottoforma di un salario pagato da altre donne che, per «conciliare» lavoro e cura come il Family Act prescrive, dovranno affidare a una baby-sitter i loro figli. Mentre risponderà almeno in parte alle legittime pretese di molte donne per le quali la maternità rischia di trasformarsi in povertà, l’assegno unico per il figlio cercherà di incardinarle alla famiglia, che si conferma una volta di più il pilastro istituzionale e simbolico di questo ordine sociale. Quanto alle donne migranti, per dare ai propri figli e alle proprie figlie l’opportunità di andare a scuola e di beneficiare di tutte le «attività educative e formative» che l’assegno promuove dovranno continuare a combattere per conquistarsi un salario, un permesso di soggiorno, e un pezzo del futuro al quale giustamente ambiscono.
Donne essenziali
La nostra iniziativa femminista non può ignorare le necessarie rivendicazioni di welfare, sussidi e reddito avanzate dalle donne, ma deve aggredire anche i meccanismi di riproduzione sessuata e razzista della società. Ciò è ancora più vero nel momento in cui le donne sono presenti in massa in quei lavori che ora sono definiti «essenziali», che per loro significano comunque una presenza sistematicamente svalutata e sfruttata tanto dal punto di vista del salario quanto da quello delle condizioni di lavoro. Negli ospedali, nelle scuole e negli uffici i servizi possono continuare perché migliaia di sanificatrici si occupano giorno e notte di limitare i rischi di contagio. Nelle fabbriche, nei magazzini della logistica e nella grande distribuzione la produzione e la movimentazione delle merci vanno avanti anche grazie al lavoro di migliaia di donne, molte delle quali migranti, che nel migliore dei casi guadagnano 600 € al mese. Per le aziende e cooperative appaltatrici non è mai stato così facile imporre turni sempre più intensi o modulare l’orario di lavoro in modo da non dover pagare gli straordinari, facendo leva sul «debito orario» che le lavoratrici devono contrarre per trovare il tempo di occuparsi dei loro figli. Per le più recalcitranti, il ricatto del permesso di soggiorno è sempre l’arma più efficace per aggirare il divieto di licenziare. Eppure, nella piattaforma dello sciopero del settore multiservizi proclamato dai sindacati confederali lo scorso 13 novembre si trova solo un accenno al fatto che in quel settore sono impiegate per la maggior parte donne e nemmeno una parola sulla condizione delle migranti. Non un riferimento ai turni di lavoro impossibili per le madri o alla legge Bossi-Fini che le ricatta. E queste differenze verranno nuovamente cancellate quando si riaprirà la stagione delle lotte per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici e di altre categorie, come se tra gli operai non ci fossero anche donne e come se il salario di tutte le categorie non fosse legato a quello delle donne che, lavorando in casa e sanificando i luoghi di lavoro, permettono a tutti di tornare a farsi sfruttare ogni giorno. In un momento in cui il lavoro delle donne viene reso ancora più invisibile dagli imperativi del governo pandemico, la nostra iniziativa femminista deve avere la capacità di rompere l’insopportabile normalità del loro sfruttamento e squarciare il velo che fa del lavoro domestico il presupposto nascosto ma essenziale della riproduzione della società.
Il movimento sociale femminista
Chi oggi inneggia alla società della cura ignora incredibilmente che in realtà esiste da sempre, perché da sempre le donne curano uomini, anziani e bambini senza poter decidere delle condizioni del loro lavoro. Non solo: ignora pure che oggi ci sono migliaia di salariate della cura che, a causa di decenni di tagli alla sanità pubblica, come infermiere e operatrici sociosanitarie vivono una sorta di precariato patriarcale che fa leva proprio sulla naturale propensione alla cura attribuita alle donne per imporre bassi salari e condizioni di lavoro sempre più oppressive. Queste donne essenziali svolgono lavori essenziali. Se sono migranti, devono farlo senza che siano riconosciute le loro competenze, perché la legge le esclude dai concorsi per le professioni mediche di cui pure oggi tutti riconoscono la necessità. La gerarchia sessuale che domina il mercato del lavoro pretende così di stabilire chi è davvero essenziale e chi invece deve accontentarsi di una essenzialità, per così dire, nascosta e letteralmente senza documenti. Come la battaglia sulla scuola di questi mesi rende evidente, dire «genitori» oppure «precari» nasconde il fatto sociale che sono soprattutto le madri che hanno bisogno che la scuola resti aperta per non perdere il lavoro, sono prevalentemente donne le insegnanti che hanno lavorato in condizioni impossibili per garantire la didattica a distanza prima e la riapertura poi, e sono in gran parte migranti le lavoratrici e le madri che ogni giorno puliscono gli istituti scolastici. La nostra iniziativa femminista non può accontentarsi di essere la quota rosa di rivendicazioni universali o di categoria, ma deve stabilire le condizioni affinché le donne possano prendere parola autonomamente contro le coordinate patriarcali della ricostruzione post-pandemica.
La difficoltà di questo momento deve essere riconosciuta. Negli ultimi anni il 25 novembre è stato un passaggio importante nel processo dello sciopero femminista, un momento di accumulazione di forza che ora è reso impossibile – almeno in Italia – dai limiti imposti alle piazze per evitare il contagio. Il problema è allora di riattivare l’intenzione dello sciopero di fare della lotta contro la violenza maschile una linea di schieramento contro lo sfruttamento e ogni forma di oppressione. Per fare del 25 novembre l’evento di un processo, anziché lo spettro di un rituale, la nostra iniziativa femminista deve rendere evidente che la violenza maschile sulle donne non è un episodio della brutalità patriarcale che può essere isolato dai rapporti sociali esistenti, perché dà forma materiale a quei rapporti. Comunicazione politica e organizzazione femminista devono essere riattivate a partire dalle condizioni in cui le donne vivono, lavorano e lottano. Dobbiamo saper riconoscere le nostre risorse e la nostra forza transnazionale nelle lotte autonome essenziali dell’Est europeo che hanno coinvolto infermiere, operatrici sociosanitarie, lavoratrici domestiche e della cura, persone Lgbtq che ostinatamente reclamano la propria libertà; nello sciopero delle donne polacche e nella quotidiana battaglia di ogni singola donna per non essere identificata con le sue funzioni riproduttive e di cura; nella lotta delle migranti che si stanno organizzando contro la violenza maschile e il razzismo istituzionale e per un permesso di soggiorno europeo incondizionato. A partire da queste possibilità e da queste forze, la nostra iniziativa femminista può affermare che le donne non sono riproduttrici coatte o salariate, non sono il modello silenzioso di una pacifica società della cura, non sono forza lavoro a basso costo licenziabile ed espellibile secondo necessità. Alla quotidiana violenza maschile, all’oppressione e allo sfruttamento delle donne dobbiamo opporre l’essenzialità politica del nostro movimento sociale contro il governo della pandemia e dentro l’agenda politica di ogni movimento. Questo è il progetto di uno sciopero essenziale che permetta di conquistare, in questa contingenza esasperante, la forza di stabilire le condizioni della ricostruzione e di opporci con una radicalità femminista ai rapporti sociali di dominio che ci opprimono.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione