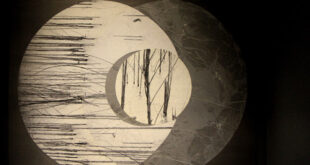Questo tempo è scardinato. Maledetto destino, che proprio io sia nato per rimetterlo in sesto. Vieni, andiamo via insieme!
Shakespeare, Amleto
La guerra ha suscitato stupore per le cose che sono ancora possibili oggi. D’altra parte, non bisognerebbe stupirsi: se non la guardiamo con occhi europei, la guerra non ci ha mai davvero lasciato, ma si è solo mimetizzata dietro l’illusione ottica di un globale a trazione occidentale. Chi però oggi sta recuperando le categorie di impero e imperialismo, incrostate di passato, non sta facendo un buon servizio a un movimento che, per praticare una politica di pace non può limitarsi a sperimentarla sui territori, ma deve battere uno spazio transnazionale in trasformazione. Il problema non è solo lessicale e neanche storico, ma politico. Non è il 1914 e il capitalismo non è nella sua fase suprema che prelude a un qualche 1917 da attendere fiduciosi. Riavvolgere il nastro della storia con la pretesa di indovinarne perfino il verso è poco utile per sondare le possibilità del presente. Il presunto ritorno dell’imperialismo, o degli imperialismi rivali come più si usa, deve essere semmai misurato sul crescente, selvaggio, disordine transnazionale prodotto negli ultimi decenni non solo dal libero movimento dei capitali, ma anche dai movimenti di lotta del lavoro vivo.
Di fronte a questi movimenti, gli schemi imperialistici sono fuori fuoco e finiscono per infliggerci una cappa geopolitica che impedisce di attraversare produttivamente questo disordine. Si tratta allora di individuare i punti di tensione del presente per pensare il rapporto tra la guerra e la lotta delle classi fuori dalle certezze delle analisi del passato.
Lo spettro evocato va comunque interrogato. Ha le fattezze di Lenin e della teoria dell’imperialismo, ovvero della coincidenza tra centralizzazione di comando politico e di capitale attorno allo Stato. Quest’ultimo si faceva veicolo del capitale e ne assecondava la smania di accumulazione. Il capitale, a sua volta, si presentava come un aggregato di monopoli finanziari, che si facevano carico della mobilitazione nazionale per le guerre imperialistiche e collaboravano al governo coloniale dell’Impero sostenendo la logica di potenza dello Stato. In realtà, già pochi mesi dopo la rivoluzione, Lenin ha definito l’imperialismo una «sovrastruttura» del capitalismo. Chiunque conosca anche solo alla lontana le disavventure del termine sovrastruttura nel marxismo puro e applicato si rende conto che l’imperialismo non è più per Lenin uno stadio supremo e definitivo, ma qualcosa di più complesso e contingente, che dopo la rivoluzione identifica la linea dello scontro tra gli Stati capitalisti e quello socialista. Ora però lo Stato socialista non c’è più e il capitalismo degli Stati (tutti) non si fonda sulla centralizzazione bancaria delle risorse finanziarie. Far rivivere l’impianto imperialistico richiederebbe dunque un gesto taumaturgico: rianimare la sovranità dello Stato-nazione e ricondurre all’interno del suo orizzonte territoriale il capitale finanziario, che oggi non è più ancorato a banche con radici ben piantate sul suolo nazionale. Con il regime di liberalizzazione che ha sostituito Bretton Woods, il capitale si è emancipato dal territorio e risulta sempre più sganciato da uno Stato che ha dovuto rinunciare a pezzi di sovranità per sopravvivere alla grande mutazione degli anni Settanta.
Tra capitale e Stato non c’è più una comunità di destino, imperiale o meno che sia, ma una relazione funzionale le cui regole non sono mai né completamente date né definitive o supreme.
E la guerra in Ucraina non ne ha certo riprodotto una qualche organica union sacrée, a meno che non vogliamo dare credito alle cianfrusaglie ideologiche dell’Occidente democratico, liberale e capitalista, in lotta contro le autocrazie e il loro capitalismo oligarchico di Stato. L’esito, insomma, è un’immagine dell’imperialismo come mera politica di potenza che risolve l’intreccio di politica ed economia in una dicotomia tra mercati e Stati nazionali, tra globalizzazione e ‘sovranismi’ di volta in volta reattivi o egemonici.
Tutto ciò non significa che in diverse aree del mondo non sia in atto un tentativo di riallineare Stato e capitale. In fondo, entrambi agiscono secondo logiche di comando dispiegate contro quei soggetti che di quel comando vorrebbero liberarsi. Ciò che manca, però, è una logica imperiale che le unifichi e che sincronizzi in maniera stabile e duratura i movimenti contratti dello Stato all’agilità con cui i capitali, finanziari e non solo, si muovono sui mercati mondiali. La globalizzazione degli anni Novanta e dei primi Duemila ha messo in tensione un rapporto storico tra Stato e capitale che il conflitto russo-ucraino non ha ricomposto e non può ricomporre. Così come non lo hanno fatto le guerre che lo hanno preceduto. Queste sono state tutte espressioni di conflitti transnazionali, perché faticavano a essere risolti con gli accordi internazionali tra Stati e non trovavano il loro posto nella fantasia adolescenziale di uno spazio globale liscio, capace di riassorbire in sé ogni contraddizione. L’equivoco del ritorno al nazionale e al sovrano, precondizione per riattivare logiche imperialistiche, sta nel misurare le condizioni del presente con i tempi in cui Clinton e Blair sentenziavano che il moto progressivo della globalizzazione era una «forza della natura» e che metterla in discussione equivaleva a discutere se «all’estate dovesse seguire l’autunno». L’autunno della globalizzazione alla fine è arrivato davvero, ma ciò non significa che si debba ritornare all’inverno degli Stati-nazione che arruolano il capitale nei propri disegni imperiali. Piuttosto,
ciò che sta avvenendo è un processo di riconfigurazione degli Stati che agiscono come piattaforme in cui il comando politico è governo e giurisdizione, limitati però dall’intermediazione e dai tentativi di coordinamento tra poteri e soggetti differenti, pubblici e privati, statali, sovrastali e regionali, in un assemblaggio ibrido e mobile che contribuisce a definire lo spazio transnazionale incontrandosi e spesso scontrandosi con altre piattaforme.
Il rapporto tra Stato e capitale deve essere costantemente ricucito in un ordine che non può che essere provvisorio. Si scambia allora per un ritorno al nazionale questo surplus di politica che deve essere attivato per tenere a freno le forze selvagge del transnazionale. In verità, neanche la forma oligarchica del capitalismo russo contempla un allineamento immediato tra Stato e capitale. Per quanto il settore energetico stia riscuotendo extraprofitti di guerra, il conflitto con l’Ucraina ha congelato asset finanziari russi e ha impedito alle imprese di Mosca l’accesso ai mercati occidentali, essenziali per dotarsi della tecnologia necessaria a mandare avanti la grande industria. Eppure, Mosca non solo si sta appropriando in Ucraina di nuove risorse, forza lavoro, territori e nodi del mercato mondiale da offrire al capitale russo, ma poiché neanche quest’ultimo ha più bandiera, lo Stato-piattaforma guidato dal Cremlino lavora da anni alla creazione di un ambiente di interscambio che include Cina, India e pezzi di Africa per fornire al capitale respinto dalle sanzioni atlantiche una via d’uscita favorevole alla valorizzazione.
Dietro le nuove politiche di sicurezza dispiegate dal blocco Nato, dalla Russia e dalla Cina si cela allora il tentativo di riprodurre un allineamento tra capitale e Stato in cui lo Stato, però, è costretto a inseguire i movimenti di quei capitali che sul piano transnazionale cercano e trovano le maggiori possibilità di valorizzazione. Questo è il piano che cercano di normare tanto il nuovo strategic concept che sarà approvato alla fine di giugno e farà della Nato una piattaforma di piattaforme ‒ sovrapponendo alleanza difensiva e partnership economica e allargandole al di là della membership formale –, quanto la strategia di «Sicurezza Indivisibile» di Mosca e la «Iniziativa di Sicurezza Globale» di Pechino, che puntano a ridisegnare un’area di interscambio commerciale, energetico e finanziario con i soggetti penalizzati dalla globalizzazione del fu Washington consensus.
Per quanto espansive siano tali piattaforme, la loro portata rimane comunque limitata rispetto alla proiezione transnazionale dei capitali. I riallineamenti che ne derivano sono perciò instabili e tendono a produrre attriti che si riversano su relazioni internazionali costantemente scosse da venti di guerra.
Nonostante lo smacco afgano, non più di un mese fa Biden si è recato in una fabbrica di armi a ricordare che la democrazia si difende con i missili Javelin e che l’operaio americano deve essere perciò orgoglioso di produrli. Ci saremmo forse risparmiati un po’ di retorica da robivecchi della storia se non avessero lasciato Sleepy Joe guardare fino a notte fonda Il dottor Stranamore. Che Biden abbia o meno imparato ad amare le bombe o le amasse già, il fatto è che nell’Occidente atlantico la manovra di riallineamento tra capitale e Stato sta passando dal tentativo ideologico di riaffermare un nesso tra capitalismo e democrazia a cui aggiungere una pennellata di verde, che di questi tempi non guasta mai. Il richiamo al (Green) New Deal risuonato sulle due sponde dell’Atlantico per respingere populisti e sovranisti è però qualcosa di più di un numero di repertorio dei tempi di Guerra fredda. Il New Deal serve a rievocare un nesso tra capitalismo e democrazia che, nella sua proiezione esterna, si afferma tramite politiche di rilocalizzazione della base materiale del mercato mondiale. La segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen le chiama politiche di friend-shoring. Si tratta cioè di ridisegnare le supply chain non per accorciarle, ma per svilupparle all’interno di un’area di amicizia, ovvero di condivisione di comuni valori liberal-capitalistici ai quali il commercio deve adeguarsi. L’obiettivo è evitare che qualche villain globale, che si chiami Putin o Xi Jinping, possa tenere in ostaggio pezzi delle catene di produzione e distribuzione generando quegli shortages responsabili di aver innescato l’attuale dinamica inflattiva. Colpita dai dazi Usa e dagli effetti del Covid sulle supply chain, la Cina si è vista in effetti sottrare capitali di investimento stranieri del valore di 50 miliardi di dollari. Gli stessi capitali cinesi per aggirare i limiti imposti dalla guerra commerciale con gli Usa stanno cominciando a voltare le spalle al comitato centrale di Pechino per prendere la via del Vietnam, meta che oggi fa gola anche al capitale americano e non solo. Quando ci si appella ai valori per normare il capitale significa che i mezzi per controllarlo scarseggiano. E invocare gli amici non è un’operazione così semplice, dal momento che non c’è più nessuna cortina di ferro che li separi dai nemici. Come dichiarato a più riprese dal segretario di Stato Blinken, lo scopo degli USA non è tanto bloccare lo sviluppo cinese, ma plasmare l’ambiente in cui la Cina deve prendere le decisioni, seguendo la strategia fondata su «investire, allineare, competere» che si annuncia come la cifra delle politiche transnazionali nel prossimo futuro.
La fine degli imperialismi significa anche questo: la fine di una politica dell’amicizia (commerciale e industriale) in cui gli Stati amici sono solo una proiezione esterna del centro imperiale. In altre parole, il progetto di riallineare capitalismo e democrazia, capitale e Stato in nome di un primato della politica da ricostituire appare segnato fin dal suo esordio da falle strutturali che lo condannano alla contingenza.
Tornando su questa sponda dell’Atlantico, dove pure si stanno delineando politiche industriali simili, la difficoltà di riallineare capitale e Stato si è palesata nel lungo stallo della politica delle sanzioni UE. Questa rende evidente che il nesso capitalismo-democrazia sta innescando un cortocircuito più che un ordine coerente e rivela le contraddizioni intrinseche al presunto primato della politica e il peso che le richieste del capitale esercita sui tavoli di Bruxelles. La difesa della democrazia, che oggi ha la faccia stanca di un teatrante di second’ordine, avrà pure le sue buone ragioni, ma di fronte a un’inflazione che galoppa le imprese europee non sono disposte ad accettare manovre azzardate che facciano schizzare i prezzi delle materie prime, anche alla luce delle turbolenze sulle supply chains. La stessa transizione energetica, il cui impatto sull’inflazione era già stato fatalisticamente accettato dalla BCE in autunno, deve fare i conti con le esigenze del capitale. Fa sempre comodo avere nel Consiglio europeo un capro espiatorio filo-putiniano, ma il fatto è che il nodo draghiano ‘pace o condizionatori’ è assai complicato da sciogliere, specie se dietro condizionatori leggiamo non solo il consumo privato di energia ma quello industriale e, più in generale, le condizioni di profittabilità di investimenti industriali. Le condizioni materiali di una guerra che assume sempre più una portata mondiale mostrano al tempo stesso come anche le rivalità tra le alleanze di vario tipo siano costrette a fare i conti con le logiche incongruenti che si intersecano all’interno delle piattaforme: la Russia continua a fornire energia a un’economia europea che non ne può fare a meno, in attesa di una transizione ecologica dai contorni e soprattutto dalle scadenze poco chiare, mentre l’Europa continua a fornire a Mosca il capitale per proseguire la guerra. Il presunto primato della politica finisce così intrappolato nel paradosso transnazionale per cui perfino per fare la guerra gli Stati devono rinunciare a frammenti di sovranità.
Più che in imperialismi rivali, le radici del conflitto in corso e di potenziali conflitti futuri vanno rintracciate nella dissoluzione dell’assetto globale che a partire dagli anni Novanta pretendeva di delocalizzare non solo la produzione, ma perfino la guerra. Questa dissoluzione non lascia in eredità semplicemente un mondo multipolare, ma segna la disgregazione della costituzione materiale di un impero mai nato. In luogo dell’ordine globale si è insediato un selvaggio disordine transnazionale, in cui a mancare non sono soltanto le regole ma soggetti legittimati a produrle. Sotto questo aspetto, i sovranismi sono stati tentativi falliti di colmare dei vuoti normativi riattivando dispositivi sovrani incapaci di stabilire un ordine che non fosse quello del populismo del capitale.
L’unico ordine oggi possibile, e che è possibile solo perché contingente e sempre sull’orlo di tramutarsi in disordine, è quello provvisoriamente prodotto dalle piattaforme, spazi di convergenza di politiche economiche, militari, energetiche ed ecologiche non sempre imputabili esclusivamente agli Stati. La piattaforma è la forma dello Stato globale e del suo comando politico: è una forza materiale che insieme ad altre deve fare i conti con la possibilità sempre presente della guerra.
Nel disordine attuale si sprecano gli appelli a una nuova Bretton Woods. Quello che manca è però un supporto monetario che ne assicuri non solo la base materiale ma anche un assetto duraturo. Per quanto sia ancora la moneta egemone, il dollaro svolge con crescenti difficoltà la funzione di equivalente generale che si è conquistato nel secolo americano. Il dollaro è inoltre colpito duramente sul piano interno da un’inflazione trainata da catene di produzione e distribuzione interrotte, dai costi crescenti dell’energia e soprattutto da corporations avide che scaricano sui prezzi quella brama di profitto che prima trovava sbocco in mercati finanziari, oggi meno allegri di un tempo. Un’inflazione non certo dovuta ad aumenti salariali irrisori, più che compensati dagli aumenti dei prezzi e di certo non sufficienti a determinare una spirale inflattiva. Come il dollaro mostra il suo volto di dio mortale, i suoi adoratori della Fed si dicono pronti a tutto per salvarlo. Tanto zelo deve però fare i conti con la doppia natura del dollaro: proteggerlo in quanto moneta nazionale alzando i tassi di interesse ne indebolisce il ruolo di valuta transnazionale, in quanto rischia di mandare in recessione l’economia mondiale e spingere i nuovi amici del friend-shoring verso altri lidi e altre monete, specie in una fase in cui Pechino inizia a sfidare l’egemonia del dollaro. La Fed e la sua moneta ammaccata si muovono così nei sentieri stretti di un altro paradosso transnazionale, mentre nessuno sembra in grado di fermare gli aumenti indiscriminati dei prezzi praticati dalle grandi corporations. Dopo tutto, il potere della Fed deve fare i conti con processi transnazionali che nessuna Banca centrale può controllare. Ed è certo che si è chiusa una stagione segnata da bassa inflazione e bassi tassi di interesse che garantivano un ambiente favorevole agli investimenti e consentivano a lavoratori impoveriti di accedere a tutta una serie di merci a basso costo. Tutto questo preme sulla carne viva di uomini e donne.
Se i progetti di sicurezza in armi promessi dalla piattaforma atlantica, da un lato, e da quella cinese o russa dall’altro richiedono tempi lunghi e presentano equilibri instabili, il tempo dell’inflazione, delle carestie e delle guerre si affretta drammaticamente.
In questo scenario da guerra mondiale abbiamo visto esplodere il Bangladesh e il Tagikistan, le cui scarse riserve valutarie impongono di scegliere tra il default o l’acquisto di carburanti e medicinali, la crisi scatenare rivolte in Sri Lanka, mentre il Pakistan scosso dall’instabilità politica è stretto tra la ristrutturazione del debito e i sussidi che tengono sotto controllo i costi dei carburanti. Non si tratta però solo del Sud globale, perché in sempre più case povere di Londra – una vecchia capitale ‘imperiale’ – si fa viva la poco entusiasmante alternativa heat or eat? ‒ riscaldarsi o mangiare? Ci aspettano tempi di alternative scanditi dalla retorica dei sacrifici, perché in fondo anche l’immaginazione del capitale e di chi lo comanda è inflazionata. Mentre l’immaginazione geopolitica parla di una sicurezza che non ci renderà mai sicuri, c’è da liberare, coltivare e far crescere un’immaginazione non allineata, che non si lascia cioè né sequestrare né abbagliare dalle promesse di allineare il capitalismo alla democrazia.
Questa immaginazione sta già praticando una politica transnazionale di pace, costruendo collegamenti contro il tempo della guerra, dei salari poveri e delle nuove e vecchie gerarchie sessuali e razziste, facendo valere attraverso i fronti e i confini il tempo della nostra sottrazione, organizzazione e insubordinazione.
In questo quadro il riferimento all’Europa, spesso evocato nei dibattiti di movimento da coloro che pretendono un maggiore realismo, si presenta sempre più opaco. Decurtata a Ovest dalla Brexit e progressivamente sfigurata da un allargamento a Est, i cui caratteri e ricatti la guerra sottolinea ulteriormente, l’Europa cessa di indicare uno spazio potenzialmente agibile in un circuito tanto virtuoso quanto problematico che avrebbe dovuto permettere di agire dal basso e dall’alto in funzione espansiva e conflittuale. Eppure, il riferimento all’Europa continua ad avere un significato, che cambia colore e contenuto a seconda delle situazioni e che ha una circolazione ambivalente, ma innegabile, soprattutto nelle aree più direttamente coinvolte dalla guerra.
Ripensare il riferimento all’Europa significa sottrarla ai perimetri istituzionali e territoriali del presente, attraversando le sue frontiere e rimettendo al centro, da Ovest e da Est, un insieme difficile ma reale di ipotesi e di pratiche politiche.
Essenziale allora sarà stare dalla parte di donne e uomini migranti che, spinti da carestie di guerra e climatiche, sfideranno i confini provvisori di quest’ordine instabile. Essenziale sarà stare dalla parte delle donne che sfidano l’ordine patriarcale della guerra, in cui anche i sacrifici sono sottoposti a divisione sessuale sicché, a Mosca, le madri russe diventano “eroiche” perché partoriscono molti figli per sostenere la nazione, mentre, in Occidente, le madri ucraine lo diventano se sostengono composte i maschi soldati o inviano nel loro paese rimesse necessarie oggi come lo saranno per la ricostruzione. Essenziali saranno quei lavoratori e lavoratrici impiegati nelle catene della produzione travolte dalle politiche di guerra e della transizione verde.
Questo tempo è scardinato. Chi può rimetterlo in sesto se non la disordinata materialità del lavoro vivo? Dovremo stare tra quelle donne e quegli uomini, migranti e lavoratori più o meno poveri, che praticano quotidianamente la loro politica transnazionale di pace. Dovremo organizzarci contro gli ordini nuovi che si annunciano a suon di bombe, per impedire il pacifico riallineamento tra Stato e capitali che sarebbe solo la continuazione con altri mezzi della guerra contro di loro.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione