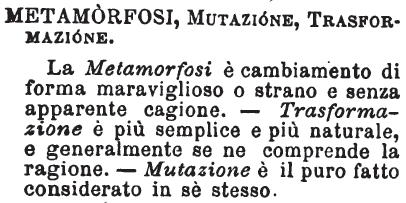 Lo scorso anno sono successe cose la cui importanza è pari solo alla nostra insoddisfazione per non averne saputo sfruttare a pieno le potenzialità. Il femminismo, i movimenti dei migranti e la configurazione logistica dei rapporti di produzione e riproduzione sociale hanno messo in moto una grande mutazione. Il femminismo è stata una novità esplosiva. Le lotte quotidiane delle donne hanno trovato espressione collettiva, di massa e planetaria, dando vita a un processo di politicizzazione senza precedenti che ha imposto lo sciopero come pratica di accumulazione di forza e sovversione sociale a livello transnazionale. I movimenti dei migranti continuano a determinare e ad accelerare trasformazioni fondamentali e complessive non solo del mercato del lavoro e delle istituzioni statali ed europee, ma dei processi di riproduzione della società globale nel suo complesso. La configurazione logistica è una sfida complessiva di cui i movimenti stanno solo ora cogliendo la centralità quale terreno di scontro, che obbliga a un ripensamento delle modalità di comunicazione, organizzazione e lotta a fronte delle trasformazioni del comando sul lavoro.
Lo scorso anno sono successe cose la cui importanza è pari solo alla nostra insoddisfazione per non averne saputo sfruttare a pieno le potenzialità. Il femminismo, i movimenti dei migranti e la configurazione logistica dei rapporti di produzione e riproduzione sociale hanno messo in moto una grande mutazione. Il femminismo è stata una novità esplosiva. Le lotte quotidiane delle donne hanno trovato espressione collettiva, di massa e planetaria, dando vita a un processo di politicizzazione senza precedenti che ha imposto lo sciopero come pratica di accumulazione di forza e sovversione sociale a livello transnazionale. I movimenti dei migranti continuano a determinare e ad accelerare trasformazioni fondamentali e complessive non solo del mercato del lavoro e delle istituzioni statali ed europee, ma dei processi di riproduzione della società globale nel suo complesso. La configurazione logistica è una sfida complessiva di cui i movimenti stanno solo ora cogliendo la centralità quale terreno di scontro, che obbliga a un ripensamento delle modalità di comunicazione, organizzazione e lotta a fronte delle trasformazioni del comando sul lavoro.
Dentro a questa grande mutazione ci sono anche piccole cose, tra le quali spiccano le prossime elezioni politiche in Italia. Visto che notoriamente il rischio delle piccole cose è di risultare di dubbio gusto, per parlare di elezioni è bene stare fuori dalla compagna elettorale. Noi non daremo indicazioni di voto o di non voto. Vorremmo invece discutere come e in che misura la faticosa politica dei movimenti sarà attraversata dalle elezioni. L’attenzione per queste ultime, infatti, nasce dal blocco evidente dell’iniziativa e da tempo, in forme e con intensità diverse, i movimenti stanno cercando una qualche dialettica istituzionale per rimediare alla difficoltà e spesso all’incapacità di consolidare nel tempo i risultati che pure ottengono. C’è però un effetto che nessuna vittoria elettorale può produrre, ovvero quello di modificare la natura precaria del lavoro contemporaneo. La grande crisi dell’ultimo decennio ha portato a brutale compimento la trasformazione complessiva del lavoro; l’ha scomposto e impoverito, per ricomporlo costantemente lungo linee sessuali e razziali, persino rinazionalizzandolo quando risulta utile al suo controllo e al suo maggiore sfruttamento. Il lavoro sembra sempre e comunque svalorizzato. Ma questa svalorizzazione del lavoro non è una disgrazia nazionale, europea oppure occidentale. È un processo globale che investe in modo diseguale tutti gli spazi del capitale, rendendo paradossalmente uguali uomini e donne distanti e diversi, rendendo simili anche se non omogenee le condizioni di sfruttamento del lavoro vivo. È un fatto politico in cui sottomissione e rivolta si presentano in continuazione una a fianco dell’altra. Nessuno può promettere di modificare questa realtà agendo in un solo punto, pertanto la sua dimensione globale fa delle elezioni italiane una piccola cosa. Non è dunque per massimalismo che diciamo che la precarietà non è riformabile, ma perché registriamo la molteplicità di collegamenti che la determinano. Nessuno può promettere un lavoro «buono», magari protetto da una riconquistata sovranità monetaria.
Gli anni non si contano all’indietro, quindi è ugualmente inutile promettere il paradiso perduto dei diritti sociali nazionali. La lotta contro questo lavoro transnazionale e tendenzialmente privo di diritti è anche il banco di prova per il reddito minimo che ora tutti vogliono concedere, dandogli ovviamente il proprio nome. Da anni un reddito minimo garantito è una rivendicazione dei movimenti. Oggi che molti parlano di reddito e se ne fa un oggetto di campagna elettorale, il problema per noi è se e quanto questo reddito si risolverà in ultima istanza in un salario della povertà. Nella sua banalità l’alternativa è secca: il reddito servirà a rifiutare le occupazioni peggiori, oppure sarà soltanto un sussidio per svalorizzare ulteriormente il lavoro? La netta opposizione a ogni ipotesi di reddito di cui Renzi si è fatto portavoce non deve trarre in inganno rispetto al fatto che tutte le opzioni oggi in campo convergono verso la seconda ipotesi. Non si tratta di difendere un lavorismo senza futuro, ma al contrario di riconoscere che proprio il discorso sul reddito è ormai una componente di uno scontro interno alle politiche neoliberali di impoverimento e coazione al lavoro. Anche se una lotta avverrà dentro e contro le istituzioni, ciò che potrebbe essere un reddito incondizionato non verrà deciso nelle urne, ma dalla capacità organizzativa che riusciremo a mettere in campo. Le elezioni, del resto, non funzionano mai da innesco per la costruzione di percorsi soggettivi. Possono registrare e amplificare la forza raggiunta da quelli esistenti oppure possono essere lo spazio di una resistenza. Non producono metamorfosi inaspettate. Fuori da ogni vuota opposizione tra istituzionalismo e anti-istituzionalismo, si tratta perciò di riconoscere la necessità di una condensazione dei processi, di un’organizzazione, della costruzione di una autonomia che non sia solo purezza ideologica e paura di ogni contaminazione. Anche l’uso di movimento delle istituzioni è produttivo se attiva processi organizzativi e percorsi di soggettivazione che non hanno nelle istituzioni il loro referente ultimo. Per questo ci sembrano vagamente inconcludenti i dibattiti su quale promessa elettorale alluda maggiormente alle cose che vorremmo. Le offerte elettorali ci sono, mancano completamente il dibattito e l’immaginazione organizzativa per mettere una seria ipoteca su quelle offerte. Il rischio è di non avere assolutamente nessuna voce in capitolo tanto ora quanto dopo il voto, quando si tratterà di rimettere al centro dell’iniziativa quella dimensione transnazionale e quantomeno europea con la quale ogni ipotesi di trasformazione deve fare i conti. Questo per noi dovrebbe essere in gioco nelle elezioni.
Se attualmente la nostra immaginazione organizzativa è certamente poca cosa, è altrettanto certo che i percorsi di soggettivazione non sono quelli di un popolo e non produrranno in nessun caso un popolo. Non perderemo tempo a domandarci quanto populista possa o debba essere la politica presente: sia quando è stato denunciato a destra, sia quando è stato invocato o rinnegato a sinistra, il populismo non ci ha mai particolarmente appassionato. Basterebbe la banale osservazione che frammentazione, segmentazione e mobilità sono fenomeni globali che hanno fatto tabula rasa dell’idea che ci possa essere un «popolo degli esclusi» che coincida con il «popolare», inteso come cultura e come identità. È dalle differenze violente che ridefiniscono conflittualmente e continuamente il «popolare» sullo sfondo del mondo che bisogna partire, non dalla sua inesistente unità o dalla sua rappresentazione. Gli esclusi non sono un popolo bell’e fatto che nelle sue assemblee popolari decide i suoi rappresentanti popolari. Questa promessa di una politica come identità non registra nemmeno lontanamente la molteplicità di figure che non fanno parte di questo popolo sempre già presente, oppure scambia il proprio quartiere – il popolo in miniatura – per l’alternativa al mondo grande e cattivo.
Il mondo, in effetti, è ancora più grande e ancora più complicato, come dimostra l’insorgenza femminista degli ultimi anni, la cui presenza impossibile da ignorare non può essere ridotta alla richiesta delle pari opportunità, né al pezzo mancante di un’identità precostituita. Le donne non sono un popolo e non sono le popolane, cioè una parte del popolo capace di conferirgli una qualche qualità più o meno naturale altrimenti mancante. L’8 marzo 2017 le donne hanno dato vita al primo sciopero sociale e transnazionale e ora si tratta di capire come tenere aperto lo spazio di politicizzazione e mobilitazione che esso ha spalancato. Certamente, solo il senso del potere determinato dal protagonismo delle donne nelle piazze di tutto il mondo spiega perché tantissime abbiano deciso di rompere il silenzio e raccontare la propria storia di violenza. Però c’è uno scarto tra le manifestazioni di massa e la circolazione di un hashtag, tra la somma di moltissime storie individuali e la presenza collettiva, tra la denuncia di ogni singolo molestatore e il riconoscimento che la violenza contro le donne è il pilastro di un intero ordine sociale che, per questo, va rovesciato. E c’è uno scarto anche tra l’estrema visibilità di alcune denunce eclatanti e l’invisibilità che ancora incombe sulle condizioni e le lotte di quelle donne che nelle fabbriche, nelle case, negli uffici o sui confini fanno esperienza della violenza sessuale come pratica sistematica di umiliazione, inferiorizzazione e disciplina dell’esistenza e del lavoro. Per questo, la novità di questo femminismo globale ci impone di chiederci come colmare quello scarto. Dalla Rojava all’Argentina, dagli Stati Uniti alla Polonia all’Iran, il protagonismo delle donne ha contestato il nesso inscindibile tra patriarcato e capitalismo avanzando una pretesa di trasformazione che mostra apertamente che «è tempo di ribellione», come suona uno slogan che lancia per l’8 marzo 2018 il nuovo sciopero femminista globale. Anche in questo caso siamo di fronte a un’opportunità e a un rischio. Il rischio è quello di riconsegnare l’8 marzo alla sua occorrenza rituale e perciò inoffensiva. In Italia questo rischio è ancora più presente, perché il nostro 8 marzo può essere spento dal vociare agitato della campagna elettorale e complicato dalle limitazioni al diritto di scioperare che colpiranno alcune categorie nei giorni che seguono il voto del 4 marzo. La vicinanza con il voto, però, può trasformare questo rischio in un’opportunità se riconosciamo che, in Italia come ovunque nel mondo, il prossimo l’8 marzo delle donne sarà l’occasione per creare un’opposizione radicale e di massa ai governi neoliberali e razzisti. Abbiamo il Piano femminista contro la violenza di Non una di meno, che non può essere considerato un punto di arrivo, la base sicura da cui far valere un diverso riconoscimento delle donne. Solo se continua a essere parte del processo che lo ha prodotto e se esprime, sotto il segno dello sciopero, la radicalità che gli hanno conferito il protagonismo e la visibilità delle donne, esso può distinguersi chiaramente dal programma elettorale con cui già qualcuno sta cercando di confonderlo. Perciò, sebbene l’8 marzo in Italia alcune categorie di lavoratrici e lavoratori non potranno scioperare, dobbiamo impegnarci a rilanciare il gesto politico dello sciopero femminista, sapendo che si tratta di uno sciopero politico e sociale che non investe solo la produzione, ma consiste nella sollevazione collettiva contro la violenza patriarcale che determina la nostra oppressione e il nostro sfruttamento. Così potremo tenere vivo il processo di accumulazione di forza che proprio grazie allo sciopero si è presentato come una novità quasi inaspettata. La scommessa non è di replicare quanto abbiamo già visto, ma di dare visibilità a coloro che non l’hanno ancora conquistata eppure lottano quotidianamente contro la violenza maschile e lo sfruttamento. Lo sciopero delle donne non è un singolo evento, ma la possibilità aperta su scala globale di cui migliaia di donne stanno approfittando per impedire la riproduzione della società come ordine e gerarchia.
Se il femminismo globale e lo sciopero delle donne sono state una novità politica, la presenza costante dei movimenti dei migranti e delle migranti rischia di essere segnata esclusivamente dalla brutale normalità con cui il governo transnazionale delle migrazioni li affronta. Il governo della mobilità europeo costituisce un elemento sempre più determinante per un’ampia regione che dal Mediterraneo si estende ormai fin dentro l’Africa. Eppure, oltre al costante e per molti versi inarrestabile movimento verso la libertà di migliaia di uomini e donne, c’è stato anche un costante attivismo tutt’altro che trascurabile dei migranti stessi. Ciò nonostante, sembra che la condizione di questi uomini e di queste donne sia quella di passare dall’indifferenza allo scandalo, dovendo fare continuamente i conti con l’emergenza in cui vengono sempre ricacciati. Mentre trasforma radicalmente il mercato del lavoro europeo e lo spinge al di là delle frontiere dell’Unione, mentre ci mette di fronte a una forza lavoro multinazionale, questo enorme movimento che attraversa il lavoro vivo contemporaneo fatica a trovare una comprensione e delle connessioni che lo valorizzino come processo aperto di soggettivazione. Eppure è inseguendo e tentando di disciplinare i movimenti dei e delle migranti che un’Unione Europea che si riproduce grazie alle sue crisi sta ridisegnando il suo spazio politico, economico e militare nella più totale indifferenza dei suoi confini istituzionali. Eppure il lavoro migrante continua a essere fondamentale nella trasformazione del lavoro contemporaneo esprimendone al massimo grado il carattere mobile, povero e transnazionale. Eppure quello con i migranti assomiglia sempre di più a un appuntamento costantemente rinviato, quando non semplicemente mancato. Non basta scoprire che i migranti sono un soggetto politico, se poi questa soggettività è ridotta alla miccia che accende l’iniziativa dei cittadini accoglienti o se viene ricondotta all’interno di schemi noti, dando vita a manifestazioni occasionali che servono soltanto a testimoniare la precaria esistenza delle organizzazioni di movimento o sindacali. L’urgenza reale che i migranti evidenziano non è solo quella di accoglierli nelle società europee, integrarli dentro ai percorsi politici esistenti o permettere un passaggio sicuro che, mentre salva qualcuno, cancella il dominio esercitato attraverso i confini e le lotte che lo contestano. La sfida posta dai migranti mostra che, al di là di ogni retorica sulla nostalgia di casa o il carattere forzato delle migrazioni, esiste oggi uno scontro tra un uso autonomo e di parte della mobilità, come pratica per sottrarsi allo sfruttamento e violenza, e il tentativo di governarla e metterla a profitto. Questo scontro, che coinvolge anche milioni di migranti interni, con e senza cittadinanza europea, fa dell’accesso allo spazio europeo e dei movimenti al suo interno altrettanti fronti di conflitto. I movimenti delle e dei migranti rendono ormai evidente il carattere compiutamente globale della società e quindi anche del cosiddetto mercato del lavoro. Appare pertanto del tutto velleitaria ogni prospettiva che pensi di poterlo riformare resuscitando una contrattazione nazionale sostenuta da politiche sovraniste, consolidando le differenze che il capitale continuamente riproduce e mette a profitto attraverso i confini. Si tratta invece di essere all’altezza di una trasformazione radicale che continuerà a modificare la composizione del lavoro vivo e soprattutto le sue modalità di espressione. Cogliere la sfida e l’occasione data dalla presenza mobile dei migranti è preliminare a ogni discorso sulle trasformazioni del capitalismo, degli spazi metropolitani, dei modi di organizzazione.
Questa sfida organizzativa risulta altrettanto evidente se guardiamo alla riconfigurazione logistica. La sfida costituita dalla logistica non riguarda soltanto la necessità di organizzare il lavoro all’interno di uno specifico comparto e lungo le filiere produttive. A giugno ad Amburgo migliaia di donne e uomini provenienti da ogni parte d’Europa hanno manifestato contro il G20, rifiutando il simulacro della democrazia globalizzata. In quell’occasione la parola d’ordine #hamburgcitystrike ha segnalato che, di fronte a un potere sociale privo di vertice, non è più sufficiente dare alla nostra lotta la forma di un controvertice. Assumere la logistica come sfida impone di misurarsi con una logica del comando sul lavoro che si esercita attraverso la sua costante frammentazione, dislocazione e ricomposizione, abbandonando la nostalgia per un passato che non può tornare. Lo sciopero nel magazzino Amazon di Piacenza mostra la complessa posta in gioco di questa sfida: la rottura dell’isolamento e dell’individualizzazione delle condizioni di lavoro è un risultato importante, che rischia però di essere ineffettuale quando si limita al tentativo di avviare una contrattazione sindacale e ad un singolo hub. Se logistica è una specifica logica del capitale, dobbiamo pensare l’organizzazione all’altezza della scala sulla quale essa si dispiega, che è quella transnazionale, e contemporaneamente alla luce della necessità di piani diversi di mediazioni sindacali e politiche che, se non possono più essere quelli pensati per la grande fabbrica, debbono allo stesso tempo tenere conto della composizione dei luoghi dove si concentra la forza lavoro. Qui non è la fabbrica che dà forma alla società, ma viceversa la società globale che irrompe in ogni posto di lavoro. La diffusione del comando lungo le catene transnazionali del valore, la segmentazione della produzione attraverso i confini, il dominio capitalistico sulle connessioni tra i diversi nodi della produzione corrispondono alla gerarchizzazione istituzionale delle condizioni del lavoro vivo secondo la provenienza, lo status giuridico, la differenza sessuale. Per costruire nuove forme di comunicazione e organizzazione all’altezza della sfida posta dalle forme della produzione contemporanea non basta dunque intervenire su singoli nodi della rete logistica, ma è necessario intraprendere una lotta per l’egemonia che abbia come ambizione di stabilire connessioni e produrre una comunicazione politica tra figure diverse del lavoro su scala transnazionale.
L’insorgenza delle donne, le trasformazioni prodotte dai migranti, la riconfigurazione logistica delle condizioni di produzione e riproduzione del lavoro e della vita ci stanno già investendo. Il punto è se saremo in grado di cogliere le sfide e le opportunità aperte da questa grande mutazione presente anche in ciò che appare costante e conosciuto.
 ∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione




